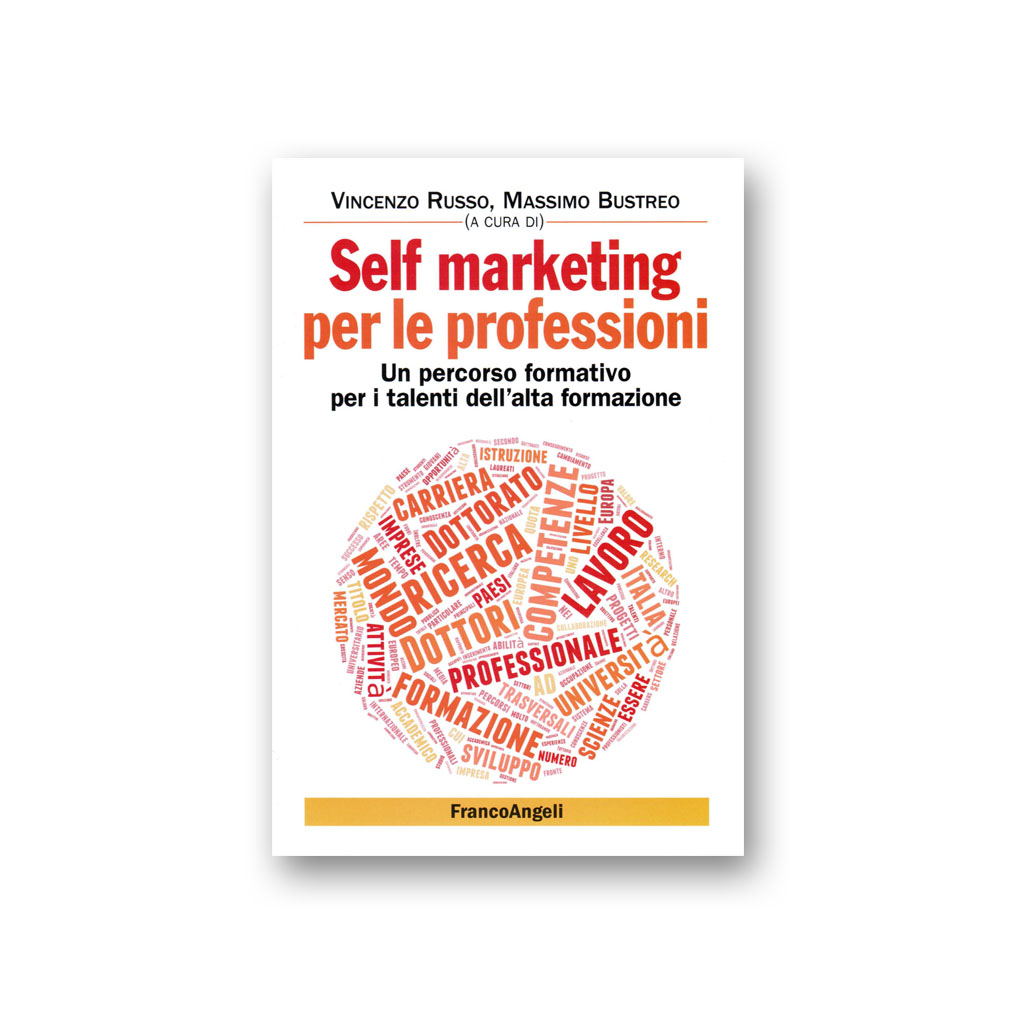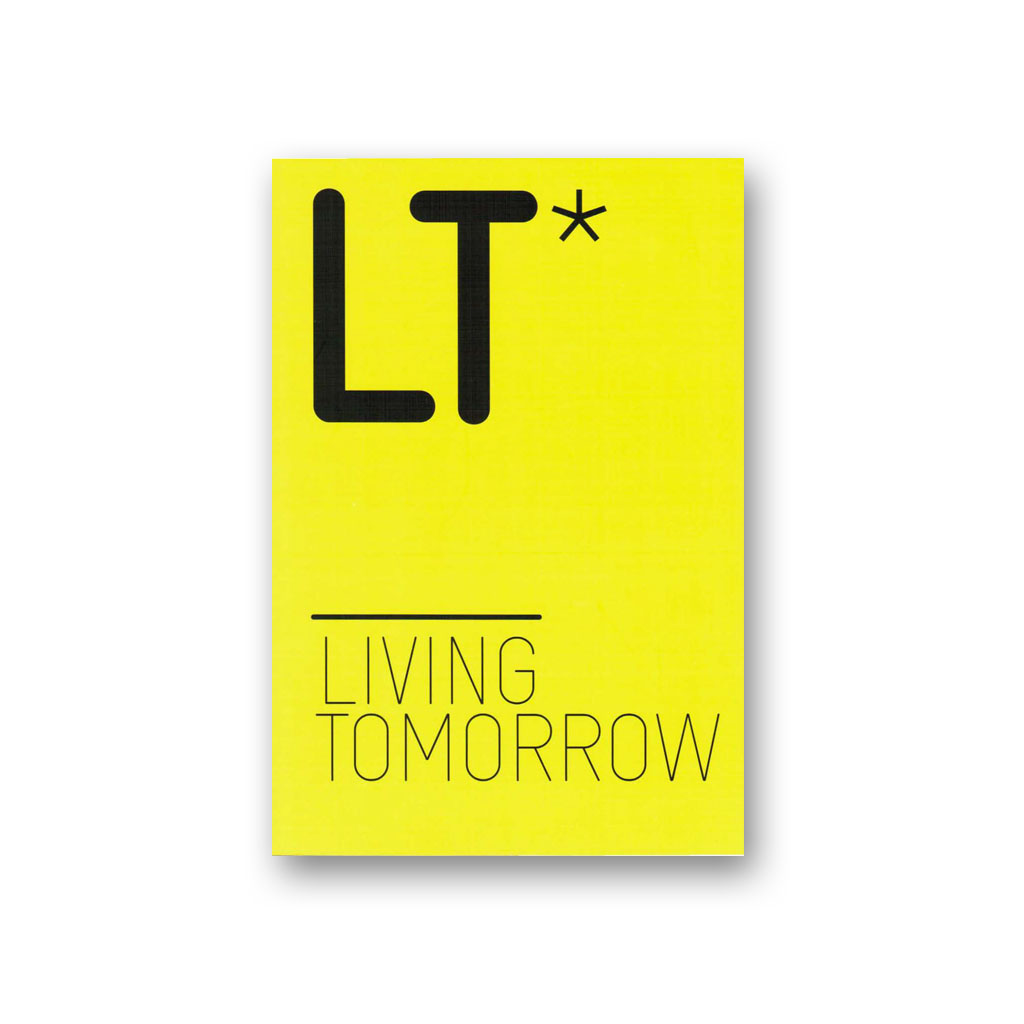(Traduzione della pubblicazione originale in lingua inglese)
[ READ ORIGINAL PUBLICATION ]
E’ ormai condiviso che gran parte della produzione ereditata dall’architettura e dall’urbanistica moderna del Novecento ha segnato un profondo distacco tra costruito e processi umani di insediamento. “Quando si pensa alla storia dell’abitare in Italia degli ultimi cinquant’anni”, scrive Franco La Cecla, “vengono subito alla mente la grande urbanizzazione, la devastazione del paesaggio e l’enorme sviluppo dell’abusivismo, sia sotto forma di “palazziname”[…], sia sotto forma di “casa sparsa” nella città-non-città”[1] (o nell’“anticittà” , come definita di recente da Stefano Boeri[2]). Proprio nell’ambito dell’abitare, secondo La Cecla, l’architettura italiana del Novecento avrebbe raggiunto i suoi risultati più drammatici: la casa, ormai sradicata di netto dalla sfera esistenziale della “strada”[3], sarebbe stata interpretata non più come luogo d’immersione di tutte le attività quotidiane ma come ambito semplificato costituito da un insieme di questioni puramente ergonomiche e funzionali. La cultura architettonica, scrive Giovanni Caudo[4], “sembra essersi appiattita sul mercato imperante e sulle domande di spettacolarizzazione che i processi di finanziarizzazione impongono; un ripiegamento verso l’immagine, talvolta con tinte ecologiche, che non ha incontrato, se non raramente, le reali condizioni delle persone e degli abitanti”.
Il distacco che ha avuto luogo in passato tra produzione architettonica e scienze umane, questione che nelle parole dell’antropologo La Cecla risuona come un segnale di allarme non privo di comprensibile coinvolgimento personale, è ormai uno stato di fatto condiviso dall’intera cultura del progetto che, al di là di ogni dimensione di scala, attribuisce ai viventi un ruolo sempre più centrale nel processo progettuale.
All’11^ Mostra Internazionale di Architettura (Biennale di Venezia 2008), il Padiglione Italiano espose dodici progetti sperimentali che, con l’azzardo tipico di quei progetti non destinati alla realizzazione, proponevano esplicitamente alcuni temi emergenti per il progetto della residenza.
Nonostante il Padiglione fosse costituito da matrici culturali molto eterogenee, vi era un comune fil rouge, costituito da una “casa possibile” che il suo curatore Francesco Garofalo descriveva come “fatta di luoghi, utenti e processi diversi dal passato”, dove l’obiettivo di passare “dalla casa all’abitare” bastava “per mettere a fuoco la differenza”, laddove la parola “abitare” “evoca tutto ciò che va oltre la costruzione dell’alloggio misurabile e definibile con standard quantitativi e pone la questione, tanto per cominciare, di dove esso è collocato, in che rapporto sta con gli altri, e soprattutto chi è il suo abitante”[5]. Se nella cultura modernista lo spazio aveva l’ambizione di generare l’individuo e le sue relazioni, oggi spetta all’identità della persona e della comunità plasmare e generare l’ambiente in cui desiderano immergersi.
Nella mostra “Small Scale, Big Change” (New York, 2010)[6], sono stati esposti, invece, progetti già realizzati, pensati come gesti pragmatici spinti dalle singole comunità e non da teorie utopiche, e dove l’innovazione includeva una rivalutazione dei metodi di coinvolgimento degli abitanti e l’assunzione di nuove forme di gestione sociale ed economica. Nell’ambito dell’housing, la mostra espose casi eccellenti come Quinta Monroy Housing di Elemental (Iquique, Cile, 2003-2005), la collaborazione tra l’organizzazione non governativa Casa Familiar da parte dell’architetto Teddy Cruz (San Ysidro, California, 2001-presente), e la trasformazione della Torre Bois-Le-Prêtre di Druot, Lacaton e Vassal (Paris, Francia, 2006-2001). Casi in cui l’innovazione della gestione sociale ed economica del progetto supera di gran lunga l’importanza di qualsiasi questione visuale e compositiva.
L’elenco di mostre, eventi e progetti che indicano questo cambio di direzione potrebbe continuare, ma ciò che ora ci interessa è rilevare due aspetti.
Da un lato è evidente che la casa, nel suo significato più generale, è al centro di un rinnovato interesse da parte della cultura del progetto. Se ne scorge l’ennesimo segnale nel fatto che la mostra “House & Home”, inaugurata l’anno scorso al National Building Museum di Washington, durerà fino al 2017[7].
Dall’altro lato osserviamo che il modo di concepire la casa si è spostato dalla priorità dello spazio e delle relazioni fisiche a quella della persona e delle relazioni tra viventi. Questa doppia polarità tra artefatto e persona, tra ruolo di spinta sociale del progetto o piuttosto quello di traino da parte delle componenti umane, è stato un confronto su cui la cultura del progetto si è spesa a lungo nel secolo scorso. Sembra interessante, dunque, provare a comprendere il senso di questa storica contrapposizione attraverso un focus sul dibattito italiano, che ha visto una contrapposizione tra visioni alternative del progetto confondersi in un’apparentemente pacifica convivenza tra discipline progettuali operanti a diverse scale.
Il progetto dell’abitare in una storia di visione alternative
Il distacco tra attività progettuale e risorse umane ha origini salde nella cultura modernista europea, la cui visione puntava a una trasformazione forzata degli uomini e rifiutava un approccio soft che prevedesse una parziale accettazione della società reale. La cultura razionalista conduceva verso la concezione di una società trainata dalla produzione, la cui priorità era quella di rispondere definitivamente ai bisogni primari degli uomini, ponendo in posizione marginale gli aspetti più intimi e mutevoli[8].
In Italia, il percorso che porta all’affermazione della tradizione razionalista nella dimensione architettonica si incrocia inevitabilmente con quel design che si impone internazionalmente per tensione verso emozioni, comportamenti e rituali umani. Negli anni ’60 e ’70 la cultura del progetto italiana vede la sovrapposizione di due grandi e contrapposte visioni: da un lato i milanesi eredi della filosofia razionalista di Ernest Nathan Rogers, e dall’altro lato il Movimento Radical nato fuori Milano, spinto da sguardo antropologico verso un totale sradicamento delle regole formali della composizione.
Il confronto iniziale tra due visioni culturali alternative e conflittuali sembra slittare, di fatto, nell’attribuzione di una diversa competenza di scala ad ognuno dei due approcci: i razionalisti mantengono l’egemonia sul fronte della scala architettonica, mentre l’avanguardia ottiene una maggiore penetrazione culturale nel design, per sua natura più predisposto ad accogliere proposte non assolutistiche, generate per una società reale in trasformazione e una cultura che “può perdere la sua connotazione unitaria”[9].
Mentre la cultura dominante, dunque, sposta il suo baricentro d’attenzione sugli spazi pubblici urbani, l’approccio antropologico portato avanti dall’avanguardia matura un interesse crescente verso le relazioni emozionali dell’ambiente domestico: per questo accade che la domesticità vera e propria, tornata ad essere un tema di progetto, viene trattata soprattutto nell’ambito disciplinare del design dell’arredo e degli interni. Il Movimento Moderno, suggerisce Andrea Branzi[10], tarda nel comprendere che l’invivibilità della città impone una nuova riflessione antropocentrica dell’abitare stesso e dimostra di considerare “progettualmente degni” solo gli spazi pubblici della città, i vuoti, su cui prova a versare invano una serie di funzioni vitali perdute negli spazi domestici. Negli anni ’60 e ’70, il design italiano e le sue avanguardie si muovono su una linea propria separata da quella principale, con obiettivi che non sono puramente ergonomici e funzionali ma umanistici ed espressivi, e dove il focus dell’attenzione non è lo spazio pubblico ma l’evoluzione della dimensione domestica.
Pertanto, se è vero che in Italia il tema della domesticità diventa quello preferenziale di un design che ha avuto origine “nei legami sociali, culturali e psicologici tra interni e loro moderni abitanti, focalizzandosi sull’arena privata della casa e dei bisogni della vita moderna”[11], è anche vero che il compito operativo di costruire interi quartieri residenziali viene affidato al progetto estetico e politico del modernismo architettonico che, come detto prima, si concentra soprattutto sulle connessioni fisiche ospitate negli spazi pubblici urbani e che realizza la sua idea di interno domestico “dentro le residenze private nella forma, prima, delle cucine razionalizzate e, più tardi, dei soggiorni in stile quasi non arredati”[12].
I progetti residenziali prodotti, oggi molto discussi, risultano spesso lontani dai bisogni umani e sociali delle persone ma forse anche fondati su principi progettuali che oltrepassano lo stesso ruolo di abitabilità[13]. E’ come se la cultura architettonica del Novecento abbia ignorato per molto tempo una radicale trasformazione della cultura abitativa, entrata fisiologicamente più nelle attese della gente che nella capacità degli architetti, degli urbanisti e degli amministratori di produrre oggetti bastevoli alle necessità[14]. “Gli urbanisti e gli architetti”, scrive Franco La Cecla, “hanno creato manufatti e ordini che non hanno mai funzionato, la gente ne ha creati altri che [per kitsch] facevano concorrenza agli spropositi dei primi”[15]. Parole che sembrano coincidere con quelle di Paolo Desideri, che vede da un lato “il mediocre sogno liberista ‘american dream’, […] patetico, della casetta unifamiliare con Biancaneve e i sette nani nel giardino”, e dall’altro architetti e urbanisti che hanno continuato a produrre mega-strutture “come Corviale, Laurentino 38, Tor Bella Monaca a Roma o Zen a Palermo”[16].
In altre parole, il contesto dei quartieri residenziali italiani ospita il confronto tra un esercito compatto di architetti, autori di rigidi schemi intellettuali, e frange disperse di persone comuni, protagoniste di un’azione disordinata e inconsapevole che potremmo chiamare “guerriglia kitsch”. E lo stesso confronto sembrerebbe incarnare la contrapposizione tra chi intende una fruizione visuale dell’ambiente e chi invece ne pretenderebbe una tattile e vissuta.
La guerriglia kitsch è interessante per la sua capacità di rivelare il margine di insoddisfazione rispetto a quanto prodotto dall’approccio razionalista: “a volte”, sostiene ancora La Cecla, “è la maniera più diretta e domestica di affermare il contrario della magniloquenza. Il kitsch ha una retorica senza fronzoli, è lì, talmente falso da non avere bisogno di essere giustificato. Se ne ride delle ipotesi di riforma della società cui, onestamente o no, si applicano politici e urbanisti”[17].
L’osservazione degli ambienti domestici della famiglia media italiana rivela un’altra questione fondamentale, ovvero un’assenza trasversale di simbologia borghese legata a specifici statuti culturali (simbologia più presente, invece, in paesi come l’Inghilterra o la Francia)[18]. Proprio in questa assenza di borghesia, oggi comune a tutto il mondo occidentale, Andrea Branzi[19] rintraccia la ragione per cui il design italiano è sempre stato pioniere nell’affrontare il tema abitativo in modo sperimentale. Un mondo umano privo di codici stabili e sicuri consentiva di interpretare la casa come “un’ipotesi di ricerca”, “uno spazio che apparteneva più alla fantasia che alla prassi quotidiana”, un “laboratorio ipotetico di sperimentazione di comportamenti evolutivi”[20].
Mentre la scuola modernista si occupava dunque di una casa del presente che era destinata ad abitanti progettati, politicamente e razionalmente immaginati in un futuro ideale, il design faceva il contrario, ovvero indagava con grande sensibilità gli abitanti del presente a cui proponeva ambienti domestici costantemente estremizzati e necessariamente proiettati nel futuro. Se da un lato la casa reale ignorava la dimensione antropologica dell’abitare ma di fatto risultava concreta e praticabile di fronte ai bisogni più immediati, la casa sperimentale, per evidenziare mutazioni trasversali alla società, tendeva a materializzarsi come in eccesso rispetto al presente[21].
Verso l’integrazione di eredità culturali diverse nel progetto dell’abitare contemporaneo
Come abbiamo visto all’inizio di questo articolo, la cultura del progetto ha ormai abbandonato le grandi utopie del secolo scorso e ha scelto un approccio più “dolce”, orientato verso le persone e le comunità, con uno spettro di differenti strategie che possono riguardare, ad esempio, l’utilizzo di materiali economici o eco-compatibili, il coinvolgimento degli abitanti nel processo progettuale o nell’interazione con gli artefatti realizzati, il rafforzamento di relazioni sociali oppure l’appagamento degli aspetti emozionali più latenti dell’individuo.
Ma in questa tendenza generale ad ascoltare più la persona e le sue relazioni, ci sono in realtà differenze che provengono ancora da quelle matrici culturali già viste in passato e prima evidenziate.
Se è vero che l’ascolto dell’abitante è ormai affermato all’interno dell’intera cultura del progetto, non possiamo trascurare che ancora persistono differenze tra chi, da un lato, organizza il proprio lavoro su interpretazioni antropocentriche e anti-specistiche (in english: anti-speciesist) degli interni[22] o sull’immaterialità di negoziazioni umane[23], e chi, dall’altro lato, intende incoraggiare con la forma relazioni sociali tra sconosciuti, attraverso interventi fisici top-down a livello urbano[24]. Da una parte, insomma, sembra esservi chi punta con approccio umanistico e psicologico ad accogliere i gesti quotidiani individuali della vita domestica ed extra-domestica, confidando che le relazioni sociali si costruiranno spontaneamente tra persone individualmente stimolate; dall’altra parte, invece, c’è chi assume interpretazioni più sociologiche e risposte più politiche, concentrando il proprio interesse sulle “relazioni sociali tra persone” piuttosto che sulle “persone”, e spostando il baricentro dalla sfera domestica ai flussi ideali di grandi spazi collettivi e urbani.
Allo stesso modo, se oggi osserviamo scuole di progetto italiane apparentemente concentrate su scale progettuali diverse (architettura o design), può capitarci di incontrare impianti formativi distanti non tanto per scala di competenza ma piuttosto per visioni culturali contrapposte, parzialmente ereditate da quegli approcci che nel secolo scorso distinguevano il filone razionalista della progettazione architettonica e quello antropologico del design. Andrea Branzi, che ha vissuto in prima persona la vicenda italiana, tende a sottolineare la differenza culturale tra le parti, funzionale da un lato e umanistica dall’altro. Luciano Crespi[25], che di recente osserva la questione in termini più applicativi, rileva una differenza di processo progettuale tra quello architettonico, più induttivo e fondato a partire dal contesto fisico, e quello tipico del design, più deduttivo e basato in prima istanza sull’astrazione di principi umani e sociali.
Esperienze come il workshop “Living Tomorrow”[26], a cui ho partecipato come tutor, incoraggiano il confronto tra studenti di differente provenienza non solo geografica ma anche culturale, relativa a scuole diversamente orientate verso l’architettura o il design.
Simili iniziative, se replicate, possono essere utilizzate per considerare più sistematicamente potenzialità, debolezze e chance di integrazione nell’incrocio tra ciò che resta dell’una o dell’altra eredità culturale. Sotto questa luce, sarebbe opportuno “riavvolgere il nastro” parlando meno di “architettura” o di “design” e più delle diverse sensibilità culturali originarie, orientate rispettivamente alla sfera visuale dell’ambiente oppure a quella tattile, a concettualizzazioni formali oppure a paradigmi umani, a relazioni fisiche del contesto oppure a relazioni tra viventi.
Mentre prendiamo atto che la dicotomia tra contesto fisico e immaterialità umana non è del tutto superata, possiamo accogliere con ottimismo il fatto che le due matrici culturali del passato si confrontino più equamente allo stesso livello di scala e che provino a conciliare con migliori risultati lo storico dualismo tra individuo e società.
[1] La Cecla, F. (2002). Una questione di gusto. La casa “made in Italy” nell’immaginario popolare. In G. Bosoni (Ed.), La cultura dell’abitare. Il design in Italia 1945-2001 (pp. 38-51). Milano, Italy: Skira, p. 43.
[2] Boeri, S. (2011). L’anticittà. Roma-Bari, Italy: Laterza.
[3] La Cecla, F. (2002). Op. cit., p. 48.
[4] Caudo, G., & Bastianelli, S. (2008). Dalla casa all’abitare. In F. Garofalo (Ed.), L’Italia cerca casa / Housing Italy (pp. 40-47). Mlano, Italy: Electa, p. 45.
[5] Garofalo, F. (2008). Introduzione. In F. Garofalo (Ed.), L’Italia cerca casa / Housing Italy (pp.). Mlano, Italy: Electa, p. 17.
[6] Exhibition at MOMA from October 3, 2010 to January 3, 2011.
[7] Exhibition at National Building Museum from April 28, 2012 to May 1, 2017.
[8] Nel rilevare le aberrazioni di questa cultura meccanicistica dell’abitare, sembra straordinariamente lucido il film di Jacques Tati Mon Oncle (1958).
[9] Branzi, A. (1984). La casa calda. Esperienze del Nuovo Design Italiano. Milano: Idea Books, p. 18.
[10] See Ibidem, pp. 149-150.
[11] Sparke, P. (2010). The Modern Interior: A Space, a Place or a Matter of Taste?. Interiors, 1(1/2), 7–18.
[12]Ibidem.
[13] See La Cecla, F. (2002). Op cit., p. 39.
[14] Desideri, P. M. (2009). Existenzmaximum: abitare dopo il Moderno. In M. Farina (Ed.), Housing conference. Ricerche emergenti sul tema dell’abitare (pp. 59-63). Roma, Italy: Gangemi, pp. 59-60.
[15] La Cecla, F. (2002). Op cit., p. 39.
[16] Desideri, P. M. (2009). Op. cit., p.. 60.
[17] La Cecla, F. (2002). Op. cit., p. 48.
[18] Branzi, A. (2002). Un paese senza casa. Modelli sperimentali per lo spazio domestico. In G. Bosoni (Ed.), La cultura dell’abitare. Il design in Italia 1945-2001 (pp. 144-163). Milano, Italy: Skira; La Cecla. F. (2002). Op. cit., p. 43.
[19] Branzi, A. (2002). Op. cit., p. 145.
[20] Ibidem.
[21] Oggi si osserva qualcosa di simile nel furniture design internazionale, dove una diffusa ed evidente assenza di codici borghesi stimola da un lato la pluralità di utopie e dall’altro il carattere permanentemente sperimentale delle proposte più rivelatrici (si pensi, ad esempio, al collettivo olandese Droog).
[22] Vengono in mente, ad esempio, Italo Rota o Andrea Branzi.
[23] Vengono in mente Teddy Cruz, Rural Studio, Elemental, James Rojas, BAR Architecten, Urban Catalyst, Urban ThinkTank e Interboro, progettisti che possono essere considerati in qualche modo affini all’Everyday Urbanism.
[24] All’interno del Padiglione Italiano nell’11^ Mostra Internazionale di Architettura (Biennale di Venezia 2008), sembrano di questo tipo i progetti di Baukuh, Ian+ e Salottobuono.
[25] Crespi, L. (2013). Da spazio nasce spazio. L’interior design nella trasformazione degli ambienti contemporanei. Milano: Postmedia Books.
[26] Workshop svolto alla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi di Istanbul dal 20 al 27 maggio 2013.